Il valore non si crea dal nulla
Il lavoro va remunerato, e il valore generato da competenze rare e molto richieste va riconosciuto
Questo è un post scritto estemporaneamente che, con il pretesto di riflettere su un piccolo caso riguardante una figura “pubblica”, sconfina sfacciatamente in alcuni aspetti della mia minuscola esperienza personale nell’ecosistema dell’informazione online.
Nella mia bolla ha ricevuto attenzione un post sull’attività pubblicistica che Selvaggia Lucarelli ha sviluppato su Substack. Il suo “Vale tutto” è il blog più seguito nella nicchia italiana della piattaforma, con circa 145.000 iscritti alla newsletter. Ciò che fa storcere il naso a molti commentatori è il numero insolitamente elevato di sottoscrittori a pagamento, circa diecimila persone, che implicano un flusso di reddito considerevole.
Molti commenti sono astiosi. Non voglio far loro pubblicità, quindi vi prego di fidarvi se affermo che il mio non è uno straw man argument. In buona sostanza, si rinfaccia all’autrice di proteggere i propri contenuti con un paywall, monetizzando l’interesse, e a volte l’indignazione, per i temi trattati nel blog.
Vado subito al punto: il rigurgito di astio collettivo puntualmente innescato dal racconto di un’esperienza di successo – non solo in campo editoriale, naturalmente – tradisce una dissonanza cognitiva tipica del pubblico italiano. Mi stupisce che i lettori non si rendano conto che ciò che stanno rimproverando all’autrice sia essenzialmente l’intenzione di guadagnare con il proprio lavoro. Spesso si tratta degli stessi lettori che, con buone ragioni, si indignano ogni qual volta sui social si diffonde un articolo –solitamente farlocco– su ipotetici datori di lavoro che piagnucolano per l’attaccamento allo stipendio dei lavoratori.
L’autonomia e l’indipendenza associate alla scelta di sviluppare una propria iniziativa editoriale su una piattaforma online sottraggono forse valore al lavoro? Ovviamente è una domanda retorica con una sola risposta possibile.
Un aspetto della dissonanza cognitiva collettiva che spesso affligge i lettori di contenuti online è la mancanza di qualsiasi empatia nei confronti di chi, quei contenuti, li scrive. Gli autori. Come se il web fosse un immenso e impersonale generatore automatico di informazione e intrattenimento gratuiti, le persone tendono a dimenticare che, dietro i contenuti migliori, c’è del lavoro. Tanto.
In parte, l’equivoco è alimentato dal declino drammatico della qualità dell’informazione. Durante la pandemia, quando i principali quotidiani italiani hanno svenduto i propri abbonamenti online, tanti lettori – compreso il sottoscritto – si sono resi conto della pericolosa sciatteria, superficialità e incoscienza con cui spesso sono redatti i contenuti, specie quelli che affrontano (tentano di affrontare) temi complessi o di divulgazione scientifica (categorie che si sovrappongono spesso).
Sentirsi utili e stupidi allo stesso tempo
Ma i contenuti non sono tutti uguali. Perdonatemi se qui, con il pretesto di Selvaggia Lucarelli, faccio riferimento all’esperienza che, oltre a conoscere meglio, mi sta fisiologicamente più a cuore, quella mia personale, e ne approfitto per esternare pensieri che da tempo oscillano sulla punta della mia tastiera.
Dietro un buon post ci sono ore di lavoro. Nel mio caso – che credo di poter serenamente estendere ad altri Substack più autorevoli del mio, compreso quello, nel suo campo, di Lucarelli – si tratta di ricerca bibliografica, studio, elaborazione, verifiche e, infine, scrittura, rilettura, revisione – e anche un briciolo di promozione a mezzo social.
Visti i temi di cui scrivo e la natura dell’impegno che dedico ad affrontarli – rigorosamente nel tempo libero, senza sottrarre nulla all’università - ho scelto di rendere il frutto di questo lavoro gratuitamente disponibile, per contribuire alla formazione di un bene pubblico (l’informazione economica) che ritengo raro e prezioso e, per sua natura, viene prodotto in quantità gravemente inferiore a quella che servirebbe.
Tuttavia, non posso non ammettere che non di rado mi capita di dubitare della sostenibilità di questo modello, poiché comporta ben poca soddisfazione, consuma tempo ed energie, e procura una dose piccola ma pungente di umiliazioni - per non parlare dei commenti astiosi.
Perché “umiliazioni”? Perché quando pubblico un pezzo su Substack – o un suo adattamento sui social – questo viene saccheggiato. C’è sempre qualche redattore di qualche testata online che copia e incolla integralmente le mie parole sul proprio sito, assediando il testo con banner pubblicitari. Spesso il testo è accompagnato dal mio nome, come se collaborassi con la testata che ha effettuato il copia e incolla, o avessi autorizzato il saccheggio. Un lavoro di ore, predato – rubato e monetizzato – in meno di cinque minuti.
Il saccheggio si reitera senza soluzione di continuità anche sui social, a opera di coloro che copiano e incollano il testo, pur accompagnandolo col mio nome, sui propri profili– senza curarsi del fatto che anche io pubblico quel contenuto sul medesimo social e che, se l’intenzione fosse semplicemente quella di far conoscere i pensieri dell’autore, basterebbe cliccare sul tasto “condividi” (o condividere il link). Anche questo è un meccanismo di espropriazione – pur senza scopo di lucro – più o meno consapevolmente mirato solo ad attrarre attenzione sul proprio profilo. Si prende il frutto di un lavoro di ore (a sua volta reso possibile da un investimento di anni, ci tornerò più avanti) e lo si pubblica in pochi secondi su uno spazio proprio, sul quale il vero autore non ha alcun controllo.
Immagino che questi meccanismi siano familiari a tutti i creatori di contenuti online e che chi scrive debba considerarli parte del gioco. Tuttavia sono umilianti. Perché, in parole povere, ti senti un coglione.
Una variante meno intrusiva e più controllabile sono le proposte di collaborazione. Ho perso il conto delle volte in cui giornalisti mi hanno chiesto di scrivere gratuitamente per la propria testata. Testate che spesso hanno un decimo o un centesimo del mio seguito. Non di rado queste richieste assumono connotati grotteschi. Per esempio, una volta mi ha chiamato un famoso editorialista che aveva appena preso la direzione di un magazine online. Ha detto, testualmente, “Anziché darli via gratis, i tuoi bellissimi articoli, perché non li dai a noi?”. Alla domanda su quanto la sua testata fosse disposta a pagare per ogni articolo, ha risposto: “Niente, ma che c’entra?”
Anche in questo caso, come ogni altra volta, la richiesta si è aperta con copiosi salamelecchi sull’arguzia, ricchezza e rigore dei miei scritti, per arrivare a una proposta che, in buona sostanza, si potrebbe rivolgere soltanto a un deficiente (nel senso che implica svilimento del suo capitale umano). Scrivi gratis per me. Oppure: regalami il tuo lavoro – che implica il corollario: il tuo lavoro non vale niente.
Come accademico del tutto indifferente alle dinamiche di potere del mondo del giornalismo, apostrofo tranquillamente l'editorialista di turno come merita - e ne traggo pure un perverso divertimento. Ma posso immaginare i sentimenti di chi, trovandosi all'inizio del suo percorso professionale nel settore, riceva proposte del genere.
Il valore vale
Scegliere di prestarsi a questi inconvenienti per contribuire a diffondere informazioni e idee che si ritiene importanti, o anche solo per far conoscere il proprio lavoro, ha dei risvolti nobili, credo. Scegliere di mettere dietro un paywall i contenuti frutto del proprio lavoro, come fanno Selvaggia Lucarelli o in piccola parte Paul Krugman è altrettanto nobile, senza alcun dubbio (e no, ironie sul confronto tra i due non sono ben accette: non stiamo parlando di titoli accademici ma di progetti editoriali). Significa ambire a essere in qualche misura retribuiti per il proprio lavoro, in modo trasparente e senza imporre niente a nessuno.
Krugman ha espresso queste considerazioni assai più efficacemente di me quando ha comunicato ai suoi lettori l’intenzione di applicare un paywall ad alcuni dei post su Substack – ferma restando la gratuità della maggior parte dei suoi contenuti.
Sto introducendo un livello di abbonamento a pagamento, alle tariffe medie che Substack mi segnala come standard per le newsletter: 7 dollari al mese, 70 all’anno.
Non toglierò nulla a chi sceglie di non pagare: i miei post quasi quotidiani, su qualunque cosa mi sembri interessante o importante, resteranno gratuiti per tutti. […]
Alcuni di voi potrebbero considerare l’abbonamento a pagamento come una sorta di “cassetta delle mance”. Scrivere questa newsletter è, di fatto, un lavoro a tempo pieno: passo molte ore a scrivere ma soprattutto a fare ricerca. Non scrivo mai improvvisando — voglio sempre avere la certezza di padroneggiare un tema prima di parlarne, e gran parte del lavoro preparatorio che faccio non compare mai nei testi che leggete.Non sto facendo tutto questo per denaro, ma da economista dovrei credere negli incentivi, e un piccolo contributo economico potrebbe rendere più facile spiegare perché continuo a sgobbare davanti al computer invece di mettermi a preparare la cena.
Krugman non è certo un caso isolato. Tanti accademici autorevoli hanno adottato questo modello di comunicazione a due livelli di pagamento su Substack, come Jared Bernstein (direttore del Council of Economic Advisers dell’amministrazione Biden), Francis Fukuyama (noto autore de “La fine della storia), Timothy Snyder (uno dei principali esperti mondiali di autoritarismo) e Timothy Garton-Ash (esperto di storia europea di fama mondiale) per citare solo alcuni esempi. Nel mondo anglosassone, l’adozione di questo modello è ovvia per chiunque crei contenuti di qualità. La generazione di un flusso di reddito sufficiente a incoraggiare questa attività pubblicistica è solo una conseguenza altrettanto ovvia, che nessuno si sognerebbe di commentare malignamente.
Tornando a Selvaggia Lucarelli, si può non essere d’accordo con le posizioni che prende nei suoi testi, o considerare trascurabili gli argomenti che tratta, ma sul piano editoriale la sua iniziativa ha meriti indiscutibili. Non si tratta di pensierini pubblicati estemporaneamente sui social media. Dietro c’è un lavoro evidentemente complesso, che va dalla costruzione di un’audience all’elaborazione di contenuti unici e interessanti abbastanza da indurre il lettore a sottoscrivere un abbonamento per leggerli. Alle ore di studio che ho menzionato riferendomi al mio caso, per Lucarelli bisogna evidentemente aggiungere un impegno costante di interpretazione degli interessi e i sentimenti del pubblico, la costruzione di un rapporto a suo modo esclusivo con una marea di estranei (che immagino molto stressante), e un lavoro presumibilmente noioso di organizzazione e promozione.
Ma non è tutto. A monte del lavoro che ciascun post richiede, c’è un investimento enorme realizzato nel corso di anni. Nel mio caso personale si tratta di una vita di studi che si è concretizzata in un percorso accademico – che mi mette nella posizione di provare a offrire al pubblico un’interpretazione di fenomeni nel guado tra economia e politica. Nel caso di Lucarelli c’è una carriera unica (e al di là di ogni dubbio e giudizio di merito, decisamente faticosa) nel settore dell’informazione e della creazione di contenuti online.
Vi prego di considerare che fin qui non ho fatto alcun cenno ai temi trattati dall’autrice o alle sue opinioni (e spero che il fatto che scrive proprio su una testata della cui linea non condivido neanche una virgola mi ponga al di sopra di ogni sospetto). Perché il mio punto riguarda altro, la sua iniziativa editoriale e i suoi aspetti economici. La decisione di mettere a frutto il proprio patrimonio reputazionale, le competenze, l’energia e la creatività, per realizzare un progetto di comunicazione autonomo e disintermediato, che possa essere portato avanti parallelamente ad altre attività in modo sostenibile (senza ammazzarsi, insomma).
In altre parole, Lucarelli ha effettuato ingenti investimenti in “capitale umano specifico”, che la mettono in condizione di creare un valore significativo col proprio lavoro. I tanti che volontariamente si iscrivono a pagamento alla sua newsletter riconoscono questo valore e, senza alcuna coercizione, scelgono di sostenere un costo per poterne fruire. Che questa disponibilità a pagare generi un flusso di reddito considerevole, anziché quattro spiccioli, non cambia di una virgola questa sostanza.
Perché è ovvio (e giusto) empatizzare con il disoccupato in cerca di lavoro che ovviamente (e giustamente) chiede di essere pagato, ma a professionisti ben riconosciuti non si riesce a riconoscere l’altrettanto ovvio desiderio di essere remunerati per la creazione di un valore evidentemente raro nell’ecosistema dell’informazione digitale? Qual è il criterio? Sembra quasi che chiunque non abbia evidenti difficoltà economiche debba farsi portatore di un obbligo morale a dar via gratis i frutti del proprio lavoro (per parafrasare le parole infelici di quell’editorialista). Come se superare una certa soglia di benessere fosse intrinsecamente sbagliato, non per questioni ideologiche ma morali. Un riflesso condizionato che ha una variante perfino più odiosa e deteriore, quella per cui qualsiasi opera realizzata nel settore della cultura debba essere distribuita pro bono, come spiega bene Enrica Nicoli Aldini.
Mettetevi nei panni di chi si prende la briga di dedicare il proprio tempo a leggere, studiare, verificare, riflettere, elaborare, scrivere, rileggere, cancellare e riscrivere per offrire contenuti complessi che informano, intrattengono, aiutano a riflettere, capire, farsi un’idea, o anche soltanto divertirsi.
Ore e ore di lavoro, che si concretizzano in un risultato che ha un valore. Qual è l’incentivo a dare via gratis questo valore per trasferirlo a dei perfetti sconosciuti? Esatto, nessuno. Quale opzione alternativa si propone, allora, agli autori? Già, non scrivere.

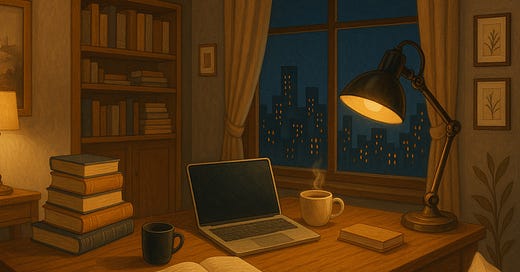


Caro Sabatini
Da lettore frequente attento e grato (e mai rapace) dei suoi utili contenuti, mi consenta una riflessione ulteriore a proposito delle paywall dei blogs. Ho la sensazione che la insostenibilità del sistema non risieda solo nella diatonia pago/non pago. I motivi di base di quella li ha svolti lei da maestro. Il problema di sostanza che resta è l’assenza di un sistema che consenta di accedere senza l’esclusiva a molte/moltissime fonti di informazione e riflessione e comunque fornire una remunerazione adeguata allo sforzo e alla competenza.
Io la Lucarelli la conosco e per questo non la leggo. Ma potrei interessarmi ad un suo contenuto (non escludo nulla…) senza dovermi abbonare al suo blog specifico ma comunque pagando il giusto.
Substack meglio di altri è una finestra su saperi infiniti e ottimi, il suo ne è la prova. Perché non creare un Sub/Substack a pagamento con accesso o variabile o illimitato (e prezzatura conseguente)? Personalmente sarei disposto a pagare per questo. Ho fatto alcune esperienze di pagamento di paywalls, ma ci si riduce a leggere la stessa fonte per le stesse persone (si ha pagato). Pagare e essere liberi di scegliere, questo è il mio punto (probabilmente non nuovo ma comunque attuale).
Selvaggia Lucarelli è quanto più distante da me, ma ho seguito il caso con interesse. Mi sembra una strategia assolutamente trasparente e legittima, e il modello di business è da valutare. Anche perché, detto fuori dai denti: di diritti d'autore tra chi scrive con regolarità non campa quasi nessuno, e le modalità con cui si fruisce dei prodotti culturali e editoriali si modificano inevitabilmente al passare del tempo.